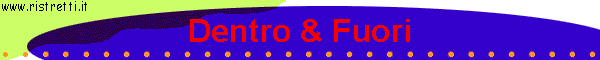
|
|
|
Avvocati
di Strada a Bologna Si occupano dei senza fissa dimora, li assistono per far avere loro una residenza, li
sostengono nelle loro necessità, li vanno ad aiutare lì dove loro vivono di
Ornella Favero e Francesco Morelli Antonio Mumolo, avvocato, è uno dei fondatori dell’associazione “Amici di Piazza Grande”, creata nel 1994 da 29 soci fondatori, la maggior parte dei quali senza fissa dimora, ed è coordinatore del progetto “Avvocati di Strada” a Bologna. Lo abbiamo intervistato perché ci interessa questa esperienza, e speriamo che nasca al più presto pure a Padova. E si occupi, se possibile, anche di chi sta in carcere, e spesso, per esempio, non può accedere alle misure alternative perché non ha un domicilio, e il Comune non ritiene che la residenza in carcere dia diritto a usufruire dei suoi servizi. Quali
sono gli obiettivi che si è data l’Associazione “Amici di Piazza Grande”? L’associazione si occupa dei senza fissa dimora e quindi dell’assistenza e del recupero sociale di queste persone e pubblica un proprio giornale, che si chiama Piazza Grande ed è l’unico in Europa interamente redatto, gestito e venduto da persone senza fissa dimora; persone tra l’altro che per mezzo della vendita del giornale ottengono anche un minimo (dal punto di vista economico) per la loro sussistenza. Cosa ben diversa è vendere un giornale da quella di chiedere la carità e quindi è anche questo un buon risultato ottenuto. Nell’associazione fin dall’inizio abbiamo fatto un ragionamento di auto-aiuto: non c’è il solidarismo, c’è la solidarietà verso quelle persone che, in quel preciso momento della loro vita, si trovano svantaggiate. Queste persone devono contribuire ad aiutarsi, per questo abbiamo creato dei laboratori di varie tipologie: una falegnameria, dove ristrutturiamo mobili che la gente butterebbe via per poi rivenderli, una sartoria, un centro dove si riparano biciclette, un laboratorio teatrale con una sua compagnia anch’essa composta da senza fissa dimora. Tra l’altro quest’anno è stata chiamata dall’Antoniano per fare alcune rappresentazioni che ci hanno dato grande soddisfazione, è stata per noi una bella proposta. Come
è nata l’idea di una tutela giuridica dei senza fissa dimora? Ad un certo punto, nella nostra attività che si sta sempre più espandendo, abbiamo avvertito la necessità di dare a queste persone anche una tutela giuridica, questo perché nel 1999 ci eravamo resi conto di un certo irrigidimento della città nei loro confronti, quasi che essere poveri fosse una colpa e non uno status, una condizione, in cui ognuno di noi si potrebbe ritrovare nel corso della propria vita; da questo irrigidimento nasceva una serie di prevaricazioni e abusi, che ci hanno convinto a portare avanti questo progetto giuridico, organizzato esclusivamente per queste persone. Così è nato Avvocati di Strada, ed è stato il primo progetto in Italia di tutela giuridica organizzata. Avete
dovuto vincere delle resistenze da parte di colleghi avvocati e del vostro
Ordine? Dal momento che questo progetto non si limita alla sola consulenza o informazione, perché noi facciamo per loro le cause in maniera del tutto gratuita, abbiamo fatto un incontro iniziale con il presidente dell’Ordine degli avvocati e tutti gli altri colleghi, sostenendo da subito questa posizione di necessità di tutela giuridica gratuita indipendentemente dall’esistenza o meno del gratuito patrocinio, chiedendo anche un confronto con il Consiglio dell’Ordine, perché in precedenza alcuni colleghi erano stati redarguiti per aver operato gratuitamente in favore di soggetti svantaggiati. In questo caso il Consiglio dell’Ordine non ci ha creato nessun problema, anzi, ha ritenuto che la nostra fosse un’attività meritoria. Quando siamo partiti con questa iniziativa eravamo solo in due avvocati, oggi siamo in ventiquattro tra avvocati e praticanti. Molti altri vorrebbero far parte di questo progetto e sono talmente tanti, che per poterli inserire abbiamo dovuto creare una lista d’attesa. Ci siamo strutturati come un vero e proprio studio legale, abbiamo un archivio, una segreteria (aperta tutte le mattine), abbiamo un numero telefonico che può essere chiamato in qualsiasi momento (ventiquattro ore su ventiquattro, perché in teoria può esserci una necessità urgente come un arresto o altri inconvenienti), abbiamo uno sportello presso la sede dell’associazione “Amici di Piazza Grande”, dove riceviamo due volte la settimana (una per il penale una per il civile). Ci siamo anche resi conto che alcune persone che frequentano i dormitori non si rivolgevano a noi (forse per impossibilità o forse per incapacità), e quindi abbiamo deciso di andare noi da loro a riceverli due sere alla settimana. A questo punto siamo disponibili quattro volte alla settimana, dopo aver preso accordi in questo senso con chi gestisce i vari dormitori per poter operare in questo modo. Inoltre abbiamo ricevuto la disponibilità di altri trenta e più colleghi che, non avendo molto tempo disponibile, si sono però offerti per almeno una - due cause all’anno gratuitamente. Ci sono poi una serie di processi che si devono svolgere in altre parti d’Italia, e per poter seguire ugualmente quelle persone (che in quel momento si trovano a Bologna in dormitori, stazione, strada…) ci stiamo attivando con una rete di colleghi che ci possono dare una mano per presenziare gratuitamente e personalmente alle udienze per i nostri clienti. Avete
a Bologna una rete di strutture che possano rispondere a tutte le necessità dei
senza fissa dimora? Abbiamo creato un rapporto con tutte le associazioni che si occupano di diritti e i centri nel territorio di Bologna, per cui se c’è una questione relativa a uno straniero (permesso di soggiorno, ricongiungimento famigliare) che vive magari in strada, noi abbiamo contatti con i centri diritti dei sindacati e non li mandiamo lì ma li accompagniamo personalmente, perché spesso a queste persone, se gli si dice di andare in un posto, poi non ci vanno. Se c’è un problema previdenziale li accompagniamo in un patronato. Abbiamo contatti con associazioni e sindacati per problemi legati al lavoro. Quindi abbiamo creato una rete di soggetti che ci hanno sostenuto fin dall’inizio e continuano a sostenerci senza chiedere nulla, nemmeno la tessera che è obbligatoria per rivolgersi a queste associazioni. Sono
tanti i casi di cui vi siete occupati finora? Noi siamo aperti da tre anni, ed io ho fatto una stima che, dal primo gennaio 2001 al settembre 2003, abbiamo affrontato 352 pratiche suddivise tra uomini e donne e tipi di casi (ora siamo a più di 400). Funzionando come un normale studio legale, garantiamo il mandato, la pratica, la privacy, per cui tutte le notizie in possesso non possono uscire dal nostro ufficio. Erano 352 casi divisi tra diritto del lavoro, separazioni, recuperi crediti, incidenti stradali, multe ed altri. Nell’area civilistica 230 casi, di cui 67 donne. Nell’area penalistica 122 casi, e di questi casi 18 donne, per un totale di 352 casi, e questo vi può far capire qual è la necessità che c’era in una città come Bologna di una organizzazione come la nostra. Tenete comunque conto che non esiste più la figura classica del clochard, esiste invece una popolazione di persone senza fissa dimora legate a casi particolari, alcolismo, tossicodipendenza, abbandono, problemi psichici, e ci arrivano sempre più persone che sono povere. Persone cadute in povertà. Ci sono i nuovi poveri. Questo è un fenomeno talmente diffuso, che da noi viene il pensionato con la minima pensione che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese e come loro tante altre categorie di persone in difficoltà. Ma
chi sono allora esattamente i vostri “clienti”? Ultimamente si vedono molte più persone che finiscono in strada non per propria scelta o volontà, adesso si rischia di finire in strada per niente, non ci sono più tutele, regole, garanzie, e grazie ai tagli del welfare non ci sono più aiuti. Ci sono una serie di problematiche, come una semplice separazione, che possono rischiare di far finire in strada una persona. Pensate appunto alle conseguenze di una separazione: divisione dei beni, la casa che va alla madre che deve dare ai figli un tetto, la possibile nascita di problemi sul lavoro e quindi il conseguente licenziamento a 45/50 anni. Questa persona nel mondo del lavoro diventa incollocabile e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, quindi questa persona finisce in strada, cioè un luogo dove non si sarebbe mai immaginata di finire. Ripeto, riceviamo sempre più spesso persone di questo genere. Ho detto questo per far capire in qualche maniera quanto è importante che non solo a Bologna ci siano sportelli di questo genere. Uno degli obiettivi che abbiamo appunto è di aprire e coadiuvare nuovi sportelli di questo genere in altre città, per poter aiutare soggetti svantaggiati che sono in continuo aumento dappertutto. In ogni città ci sono associazioni che si occupano dei senza fissa dimora, ma spesso non ci sono sportelli legali che si occupano della tutela legale e dei diritti di queste persone. Esiste
in altre città l’esperienza degli avvocati di strada? Una esperienza analoga è nata a Verona, al momento poi abbiamo contatti su Roma con una serie di associazioni tra cui quella dell’ex senatore Manconi, che da poco è stato nominato garante dei diritti dei detenuti ed è interessato a un’iniziativa analoga, abbiamo contatti a Torino con Don Ciotti, dopo che i colleghi di Torino (che collaborano con lui) sono venuti a trovarci a Bologna per vedere come ci siamo organizzati, per poi provare anche loro a fare qualcosa di simile, inoltre abbiamo contatti di questo tipo anche su Milano e Napoli. Ecco, noi pensiamo che esperienze del genere debbano essere estese il più possibile anche in altre città. Tra l’altro, rispetto alle risposte che abbiamo avuto noi, posso dire che sono davvero tanti i colleghi disposti a offrire almeno un pomeriggio al mese del loro tempo per far parte di un progetto di volontariato e solidarietà del genere. C’è
qualche causa particolare che avete fatto? La nostra pratica numero 1 era un signore che da due anni e mezzo dormiva in un dormitorio pubblico, aveva perso la residenza del suo Comune di provenienza e l’aveva chiesta presso il Comune di Bologna. Il Comune non concedeva la residenza a nessuna delle persone che dormivano nei dormitori pubblici, pur essendo i dormitori gestiti dal Comune stesso, così gli abbiamo fatto causa, per ordinargli di dare la residenza a quella persona, perché la residenza è un diritto di tutti i cittadini, senza non si ha diritto nemmeno all’assistenza sanitaria, non si hanno diritti come votare, non si può avere un libretto di lavoro, una partita IVA. In sostanza non si è cittadini, e in queste condizioni si può solo andare ancora più a fondo. Questa persona aveva trovato un lavoro, ma senza la residenza non poteva essere assunta. Il Comune di Bologna si è costituito in giudizio insistendo sulla sua tesi, ha perso, quella persona ha ottenuto la residenza, insieme a lui hanno ottenuto la residenza altre 300 persone che dormivano presso i dormitori, da quel momento siamo passati anche a quelle persone che non dormivano presso i dormitori ma per strada, in stazione, perché i dormitori ospitano se va bene il 60% dei senza fissa dimora, l’altro 40% rimane in strada, però anche queste persone meritano la residenza, la possibilità di trovare un lavoro, di essere assistiti dal servizio sanitario nazionale. Ora tutte queste persone hanno o possono avere la residenza a Bologna, purché dimostrino di essere reperibili in un tal luogo della città ad un controllo dei Vigili Urbani. In ogni città esistono vie fittizie, a Bologna è via senza tetto, in altre via senza nome, esistono vie fittizie in cui il comune deve dare la residenza a tutte queste persone, solo che questo non tutti lo sanno. Questa è stata la nostra prima causa, poi ne abbiamo fette altre, ma un paio soprattutto di una certa rilevanza, su questioni relative ai minori. Spesso ci sono persone che vivono in strada che hanno problemi legati all’alcolismo, alla tossicodipendenza, persone che hanno anche dei figli. Magari vivevano in un appartamento, poi perché non hanno pagato il canone di locazione o per altri motivi si trovano in strada con gli stessi figli, e bisogna aiutarli. Preciso che è giusto e corretto che gli assistenti sociali si occupino dei figli insieme al Tribunale dei Minori, perché l’interesse prevalente è il loro. Ci sembra però un po’ scorretto che gli assistenti sociali e lo stesso Tribunale non si rendano conto che, se una persona si trova in quel momento in quello stato (tossicodipendenza, alcolismo o altro), quella persona può tornare a uno stato di normalità. Prendere questi bambini e affidarli direttamente a soggetti terzi, quindi impedendo completamente per il futuro ai genitori di vederli, non è questo un aiuto, anzi, forse rappresenta la goccia che fa traboccare il vaso in senso negativo per quella persona, convincendola in maniera definitiva di non avere più nessuna speranza. I soggetti che normalmente si trovano in questa situazione hanno una famiglia, genitori, fratelli, sorelle, in questi due casi abbiamo impugnato la decisione del Tribunale dei Minori di dare in affidamento i figli chiedendo che venissero affidati in un caso alla sorella e nell’altro al padre. In un caso ci è andata bene subito, nel senso che abbiamo vinto e il bambino è stato affidato alla sorella, nell’altro caso la nostra richiesta è stata respinta con una considerazione, che se i genitori non sono stati bravi ad educare la figlia, che oggi si trova in questa situazione, figuriamoci se possiamo dargli in affidamento i nipoti (non è una barzelletta, è verità). Ovviamente questa decisione l’abbiamo impugnata, in secondo grado la decisione è stata cassata, i bimbi sono stati affidati ai nonni, la ragazza in questo momento si trova in comunità e sta seguendo un percorso che la tirerà fuori dalla situazione in cui era e le permetterà un domani di riavere i suoi bambini. Queste sono due delle tante esperienze che abbiamo affrontato e che vi volevo raccontare. Avete
anche prodotto dei materiali utili per gli utenti del vostro servizio? Abbiamo pubblicato una serie di opuscoli: il primo riguarda l’Avvocato di Strada, spiega come siamo nati, come siamo cresciuti e come ci siamo organizzati. Poi abbiamo pensato che le persone senza fissa dimora hanno necessità di sapere molte cose, non hanno solamente la necessità di avere un consiglio legale. Chi vive a Bologna, senza soldi, senza nessuna possibilità, chi dorme in stazione, forse vuol sapere dove può andare per lavarsi, per nutrirsi, per vestirsi e andare a dormire, dove può trovare un lavoro, dove può trovare assistenza medica. Anche riguardo a questi problemi abbiamo fatto un opuscolo che si chiama “Dove andare per…”, che contiene l’elenco di tutti i posti dove la persona può rivolgersi in caso di bisogno e i relativi numeri telefonici Ne abbiamo stampate 2000 copie e distribuite nei dormitori, davanti alla stazione e in tutti quei luoghi dove c’è una considerevole concentrazione di soggetti disagiati, è tascabile, comodo da portare con sé ed è un aiuto in più. Ora stiamo preparando un nuovo opuscolo, un “Manuale dei diritti della povertà”. È un manuale senza nessuna pretesa, che però racconta i casi emblematici in cui ci siamo imbattuti in questa nostra attività, questo manuale credo verrà pubblicato non più tardi dell’inizio dell’estate. L’intervista ad Antonio Mumolo ci ha suggerito una considerazione: che se si riuscisse a dare una assistenza di questo tipo anche ai detenuti più disagiati, che non hanno alle spalle una famiglia che li sostenga, forse si “aggredirebbe il problema” a monte, impedendo a tanti di loro di andare a ingrossare, a fine pena, le fila dei senza fissa dimora.
Il
carcere non-carcere? Funziona anche nelle zone più “a rischio” Come dimostra il caso Calabria Uno
dei punti di forza del reinserimento dei detenuti è rappresentato dalle tanto
controverse misure alternative alla detenzione. Quei percorsi assistiti di
inclusione sociale che, perfino in una regione difficile come la Calabria, hanno
avuto successo nel 96 per cento dei casi A
cura di Marino Occhipinti Un Centro per coordinare tutte le iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. Borse-lavoro stanziate dai Comuni. Progetti di reinserimento sociale. Il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Catanzaro, diretto dal dottor Paolo Quattrone, crede nelle potenzialità del territorio e nell’osmosi che si deve creare fra il territorio e il carcere. Non solo: la Calabria crede anche nelle misure alternative alla detenzione, che negli ultimi anni si sono rivelate efficaci, in questa regione, per la quasi totalità dei casi. Di statistiche - ma anche di progetti, attività e bilanci - abbiamo parlato con Lucia Catalano, che conosce bene la realtà penitenziaria calabrese perché in carcere lavora quotidianamente, e da parecchi anni, come assistente sociale del Centro servizi sociali adulti di Reggio Calabria. Dottoressa
Catalano, secondo la sua esperienza professionale diretta, le misure alternative
alla detenzione hanno una reale funzione sociale e un’autentica efficacia? Può
tracciarci il quadro relativo alla sua regione? Penso che il carcere non possa essere l’unica risposta per le persone che hanno commesso un reato. Dal 1987 a oggi, in Calabria hanno potuto godere dei benefici alternativi, senza passare dal carcere, circa 51 mila persone. Su 537 casi di esecuzione penale esterna nella provincia di Reggio Calabria, seguiti nel 2001 dagli operatori reggini, soltanto 27 sono stati revocati. A Cosenza, 48 su 586, a Catanzaro 31 su 1.012. Cifre confortanti che si scontrano con la percentuale di recidiva del 70 per cento che produrrebbe il carcere e che danno ragione a chi, nel 1975, introdusse la riforma carceraria, poi modificata nel 1986 con la legge Gozzini. Sull’intero territorio regionale nel 2001 hanno fruito dell’esecuzione penale esterna circa duemila persone, e a giudicare dai dati forniti dai Centri servizi sociali adulti presenti nella regione, risulta pienamente riuscito l’esperimento dell’esecuzione penale esterna: le revoche, infatti, sono ammontate a un esiguo quattro per cento. Cosa
si fa per chi esce dal carcere in misura alternativa? I Comuni della provincia, come da intese, hanno previsto impegni di spesa da destinare alle borse-lavoro per i soggetti in esecuzione penale esterna. Per gli ex detenuti, invece, sarà costituito un Centro che promuoverà e coordinerà tutte le iniziative che il Provveditorato regionale della Calabria attuerà in tema di inserimento lavorativo dei condannati, dei dimessi dalle carceri, delle famiglie dei detenuti. Il Centro nascerà in collaborazione con il Consorzio Nova Spes di Milano, particolarmente qualificato nell’occupazione per le fasce sociali svantaggiate. Questa continuità lavorativa tra dentro e fuori costituirà dunque una garanzia di recupero sociale. La promozione dei poli lavorativi all’interno degli Istituti prevede anche lo sviluppo di attività produttive interne, industriali e artigianali, che rispecchino le esigenze del mercato. Com’è
la situazione nelle carceri calabresi? Nella nostra regione ci sono dieci case circondariali, una casa di reclusione già avviata e un’altra in costruzione ad Arghillà, vicino Reggio Calabria. Direi che abbiamo attuato il principio della territorialità della pena, per dare un taglio netto al fenomeno dei viaggi lunghi, faticosi e costosi che i familiari dei detenuti devono spesso affrontare. Quali
progetti e attività “trattamentali” promuovete, per il reinserimento dei
detenuti e in prospettiva del loro rientro nella società? Esistono progetti e attività utili al reinserimento, sia per chi sconta la pena in carcere, sia per chi è prossimo alla dimissione o è già stato dimesso. Il Progetto Athena* per esempio, un progetto sperimentale che ne comprende altri, si propone di stimolare il sociale a consolidare l’impegno per i detenuti, affinché la realtà carceraria ottenga opportuni e possibili sostegni da parte della comunità civile. Il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, la Regione Calabria, gli enti e le associazioni fungono da supporto con l’ausilio di interventi pedagogico-riabilitativi, per incamminarsi verso un carcere dalla fisionomia trattamentale e non più solo rivolto alla custodia. Un carcere dove tutti gli operatori parteciperanno attivamente perché l’uomo detenuto sia messo in grado di gestire in maniera responsabile non solo la propria detenzione, ma anche il suo rientro nel suo contesto sociale. Per
il carcere e per i detenuti - ma crediamo anche per l’amministrazione
penitenziaria - i volontari rappresentano una risorsa determinante: come
riuscite a lavorare con loro, a coinvolgerli? Anche in questo settore abbiamo vari progetti, a partire dalla formazione permanente per gli operatori penitenziari, degli enti locali e del volontariato. Il Provveditorato della Calabria ha già avviato un’azione di valorizzazione, promozione e coinvolgimento del volontariato all’interno degli istituti penitenziari e presso i Centri servizi sociali adulti. A Reggio Calabria, fra ottobre e dicembre del 2003, abbiamo organizzato un corso di formazione per i volontari penitenziari di tutta la provincia. L’iniziativa ha trovato una larga adesione, con oltre 120 domande di iscrizione. L’obiettivo dell’Amministrazione penitenziaria è stato quello di avvalersi di un volontariato preparato, motivato e consapevole del ruolo, quindi utile al definitivo reinserimento dei condannati nella società. Attraverso protocolli d’intesa con numerosi enti locali della provincia e della regione, si sono attivati gli sportelli informativi in alcuni comuni della provincia reggina e presso i Centri servizi sociali adulti regionali. Su proposta del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sono stati attivati numerosi altri progetti per i soggetti in esecuzione penale esterna come “Ali d’Autore” (progetto “Lettura” guidato e commentato), “Polaris” e “Giustizia Riparativa”. Ecco,
la giustizia riparativa, della quale si parla sempre di più: chi avete
coinvolto in questo progetto? Su iniziativa del nostro Centro servizi sociali adulti, è stata firmata una convenzione con il Tribunale di Sorveglianza di Reggio, in partenariato con numerosi comuni e soggetti non profit per la realizzazione dei progetti di giustizia riparativa. Lo scopo è quello di promuovere una cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima e autore del reato: azioni di riconciliazione, di riparazione del danno, anche attraverso attività gratuite a favore della collettività, enti o associazioni di volontariato, in particolare per i condannati in affidamento in prova al servizio sociale. Secondo
lei, è dunque possibile agire per abbattere la recidiva? Sì, e vorrei esprimere un pensiero ai vostri lettori detenuti: io credo che sia possibile uscire da situazioni di devianza se, alla volontà dello Stato di offrire delle opportunità, si accompagna la volontà del soggetto che ha sbagliato di mettersi in discussione impegnandosi in un concreto cammino di responsabilità. *Il
progetto Athena È un progetto globale che ne comprende altri: 1) Progetto Giovani: imminente apertura dell’Istituto sperimentale a custodia attenuata per giovani adulti a Laureana di Borrello (Reggio Calabria). È un progetto di recupero sociale dei giovani coinvolti nella devianza, attraverso la realizzazione di un circuito di detenzione fondato su una logica educativa che offra percorsi di risocializzazione a trattamento avanzato. Una sfida per sottrarre linfa vitale alle organizzazioni criminali. Per accedere alla struttura penitenziaria sono richiesti alcuni requisiti: - il consenso dell’utenza, quindi la volontarietà di affrontare un percorso socio-rieducativo, attraverso l’adesione a un patto trattamentale con l’Amministrazione penitenziaria. L’ottica è quella di porre alla base l’assunzione di precise responsabilità; - l’età fra i 18 e i 34 anni; - l’appartenenza al territorio: il detenuto dovrà essere residente nella regione dove si trova la struttura; - la bassa pericolosità sociale: i detenuti da ammettere nel circuito a custodia attenuata non dovranno presentare particolari esigenze di custodia; - la posizione giuridica di definitivi o di ricorrenti. I detenuti saranno selezionati dal “Gruppo Filtro” presso l’Ufficio trattamento intramurale del Provveditorato della Calabria. 2) Progetto Spartacus: consiste nell’apertura di sezioni a custodia attenuata per tossicodipendenti presso gli Istituti penitenziari di Reggio Calabria, Catanzaro, Paola, Crotone e Cosenza. In questo ambito, è in cantiere un progetto di un nuovo Istituto di pena a custodia attenuata per malati di Aids a Oppido Mamertina (Reggio Calabria). 3) Progetto Voci Invisibili: trattamento, cura e prevenzione del disagio mentale nel sistema penitenziario. 4) Progetto Sexual Offenders: progetto sperimentale per il trattamento dei soggetti autori di reati sessuali in esecuzione penale. 5) Progetto Mosaico: iniziative trattamentali a favore degli stranieri. 6) Progetto Donna: pone particolare attenzione sugli interventi trattamentali per le donne detenute, con il coinvolgimento delle realtà associazionistiche locali. Si tratta di attività e di laboratori di espressione, in un percorso di affermazione delle pari opportunità anche nel contesto penitenziario, dove vi è predominanza numerica degli uomini. Il progetto è stato attivato nelle sezioni femminili di Cosenza e Reggio Calabria. 7) Progetto Interventi: per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, comprendente borse-lavoro d’inserimento sociale. 8) Progetto I.L.D.E.: interventi per il reinserimento lavorativo dei detenuti negli Istituti di Catanzaro, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia, dove è prevista la promozione di cooperative interne costituite dai detenuti. Le cooperative esterne, strettamente collegate con quelle interne, saranno supportate dal terzo settore del territorio. Vi sarà una continuità tra dentro e fuori che costituirà una garanzia per il soggetto in uscita e per il territorio stesso. Il percorso di orientamento, formazione e avviamento al lavoro verrà assistito da operatori specializzati.
Un
teatro che migliora la capacità di comprensione e relazione L’esperienza
del Teatro dell’Oppresso di Parigi in un carcere minorile del Marocco di
Francesco Morelli Rui Frati, brasiliano di origini italiane, è il direttore del “Teatro dell’Oppresso” di Parigi. L’ho incontrato ad un Master di relazioni interculturali, organizzato dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Padova, dove lui era chiamato a raccontare la sua esperienza artistica e sociale. Dopo cinque minuti di chiacchiere ci parlavamo come fossimo vecchissimi amici. Che
cos’è il “Teatro dell’Oppresso”? È un progetto di lavoro che, nel corso degli anni, si è ingrandito e diversificato. Oggi non abbiamo più l’idea che il teatro può cambiare il mondo, piuttosto crediamo che possa servire, inserito in un contesto di interventi tra loro complementari, a migliorare la capacità di comprensione e relazione, quindi a favorire il superamento dei problemi che nascono quando persone di diversa cultura e condizione sociale devono vivere assieme. Il
vostro nome fa pensare a Bertold Brecht, ad un teatro che dà voce ai poveri e
agli emarginati. Inizialmente lo spirito del progetto era un poco questo. Io non sono stato tra i fondatori, arrivai quando il Teatro dell’Oppresso esisteva già da 10 anni ed era riconosciuto anche dal mondo politico, come esempio di impegno a favore dei cittadini più deboli. Però mi sono accorto subito che qualcosa non funzionava: il Comune di Parigi ci pagava perché andassimo nei quartieri più degradati e coinvolgessimo la gente in spettacoli–verità, dove poteva esprimere il proprio malcontento e chiedere ai governanti di fare leggi migliori. A questi spettacoli arrivavano sindaci, assessori, ministri, che applaudivano e facevano tanti complimenti, ma poi non facevano niente per venire incontro alle richieste della gente. Dopo qualche mese se andavi a cercarli, ti dicevano: “Avete fatto un bel lavoro, l’anno prossimo ve lo rifinanziamo senz’altro…”, però non parlavano dei problemi sociali visti attraverso lo spettacolo. Come
coinvolgete la gente comune nei vostri spettacoli? Fate dei provini, come alle
trasmissioni televisive? No, assolutamente. Noi andiamo in una piazza, ci mescoliamo alla gente, senza fare capire che siamo attori, e poi due di noi cominciano a discutere ad alta voce di qualche tema “scottante”, ad esempio sulla presenza degli immigrati. Altri due iniziano a loro volta a discutere, prendendo spunto dai primi, e così via, finché tutto il gruppo di 12 – 15 persone è impegnato a dibattere e la piazza si riempie di gente incuriosita, che naturalmente si coinvolge e partecipa, a volte anche in maniera troppo accesa, alla discussione collettiva. A questo punto arrivano due videooperatori, che riprendono delle scene. Non facciamo delle scene di nascosto, quindi chi vuole può non essere ripreso. Ma devo affermare che di solito, davanti alla telecamera, chi stava protestando rincara anche la dose. Prima
hai detto che questo sistema non funzionava… cosa è cambiato dopo il tuo
arrivo al Teatro dell’Oppresso? Constatato che di rivoluzioni con il Teatro non se ne può fare (e, comunque, che neanche le rivoluzioni riescono a cambiare il mondo… ma questo è un altro discorso!), ci siamo convinti della necessità di lavorare all’interno di progetti più ampi, che intervengono nel campo sociale sui vari fronti e con vari strumenti, uno dei quali può essere, appunto, il Teatro. Ci
puoi fare degli esempi di “progetti ampi” ai quali partecipate? Attualmente stiamo collaborando con una ONG inglese, la Penalty Reform International, che si prefigge di migliorare le condizioni di detenzione in molti paesi, soprattutto in Africa, ma anche in Asia e nell’Europa dell’Est, in Sud America. Abbiamo lavorato anche nel Burundi, per aiutare i sopravvissuti al genocidio degli anni ‘90; nel Nepal, con un programma in difesa dell’identità culturale delle minoranze etniche Hindi, e in Brasile, con i ragazzi di strada di San Paolo. Che
cosa fa esattamente la ONG “Penaly Reform International” e quale è il
vostro ruolo all’interno delle attività dell’associazione? Questa organizzazione cerca di rendere le carceri dei luoghi più umani, partendo dalla formazione del personale che ci lavora: medici, infermieri e, naturalmente, sorveglianti. Inoltre collabora con i vari governi per la costruzione di nuovi penitenziari secondo criteri di vivibilità e non è facile convincere questi paesi a spendere i soldi per fare “stare meglio” i propri detenuti, quando anche i propri cittadini liberi hanno grossi problemi di sopravvivenza. Il nostro compito è quello di formazione dei sorveglianti a modalità di relazione, anche non verbale, che possono prevenire l’insorgenza di conflitti con i detenuti. In altre parole, a saper “leggere” comportamenti e atteggiamenti prima che questi degenerino e ad agire nella maniera più adeguata perché la tensione non sfoci nella violenza. Quindi
siete entrati in carcere? Per il momento abbiamo fatto un solo intervento dentro il carcere ed è stato in Marocco, nel penitenziario minorile di Casablanca. Ma ci sono altri progetti simili in preparazione. Che
situazione avete trovato, in questo carcere minorile? La direttrice è una persona straordinaria e questo istituto è il migliore, come condizioni di vita, tra tutte le carceri del Marocco. Lei, in ogni modo, ci ha detto più volte che ciò che stavamo facendo nel suo carcere sarebbe stato impensabile in qualsiasi altro penitenziario. Noi siamo entrati in 10 e avremmo dovuto tenere dei laboratori con i circa 200 guardiani, che là si chiamano “sorveglianti educatori”, ma che poi di “educatori” hanno ben poco… perché in genere hanno un bassissimo livello culturale. Però, subito, abbiamo visto e capito che bisognava fare qualcosa anche per i ragazzi detenuti e, quindi, abbiamo contrattato con la direttrice di fare alcuni laboratori anche con loro. Il problema è che c’erano 900 ragazzi, divisi in stanzoni di 50 – 60, e mancavano gli spazi per fare i laboratori teatrali. Alla fine l’unica soluzione trovata è stata di entrare nelle celle e lavorare lì. Tre ore al mattino e tre nel pomeriggio. I ragazzi più giovani, avevano 13 anni, i più grandi 20 – 21, poiché la direttrice cercava di non fare passare i ragazzi maggiorenni nel carcere degli adulti, dove sarebbero stati peggio. Ma quello che ci ha meravigliato è che erano tutti maschi: in quel minorile non c’era un reparto per le donne. La direttrice ci ha spiegato che le ragazze detenute erano assieme alle donne adulte in un carcere separato, che si trova poco distante da quello maschile. A quel punto volevamo incontrare anche le ragazze, però non c’era il permesso di entrare nel carcere femminile. Abbiamo chiesto alla direttrice se era possibile fare portare un gruppo di ragazze nel maschile. Prima ci ha risposto che eravamo pazzi; poi ci abbiamo ragionato un po’, e alla fine ha concesso il permesso di fare venire 30 ragazze, con un pullman, e di tenerle con noi per due ore ogni pomeriggio, nel cortile. Quando sono arrivate queste ragazze, che avevano dai 13 ai 18 anni, erano molto impaurite, perché non capivano bene il motivo per cui le portavano nel carcere maschile: temevano che le violentassero, qualcuna teneva il volto coperto con il velo. Ci sono voluti alcuni giorni per convincere loro che non volevamo fargli del male. Molte parlavano solo arabo, quindi era necessario il continuo intervento dei sorveglianti, per tradurre in francese ciò che dicevano e in arabo ciò che dicevamo noi. Quanto
è durato il vostro intervento nel carcere minorile di Casablanca? Noi siamo entrati per un mese intero, invece altri operatori della ONG hanno programmi di collaborazione pluriennali, anche se più diluiti nel tempo. Al
termine dei vostri laboratori avete potuto trarre il bilancio dei risultati
raggiunti? Che riscontri avete avuto? L’ultimo giorno abbiamo organizzato una rappresentazione collettiva, nel cortile del carcere, alla quale hanno partecipato un gruppo di sorveglianti, uno di ragazzi e uno di ragazze. Gli accordi erano che i ragazzi e le ragazze non dovevano venire a contatto, ma ad un certo punto abbiamo visto che, da una parte e dall’altra, cominciavano a farsi dei piccoli segni con le mani, perché molti si conoscevano, erano fratelli, o anche fidanzati, e magari non si vedevano da qualche anno. Poi è successo un cataclisma, i due gruppi si sono mescolati, tra abbracci e baci e pianti, i sorveglianti non sapevano più che fare e guardavano noi, ma pure noi eravamo impotenti. Per riportare la calma ci abbiamo messo mezz’ora e poi nessuno aveva più voglia di fare teatro, ma quello che era appena successo per noi era il risultato migliore. Quindi
la tua prima esperienza di teatro-carcere è stata positiva: la vorresti
ripetere, uguale, o cambiando qualcosa nel metodo di lavoro? La ripeterei, però con metodi diversi. In carcere non puoi dare voce ai problemi dei detenuti e poi uscire e andartene tranquillo a dormire in albergo. A Casablanca è successo che una ragazza si è lamentata dei maltrattamenti che subiva nel carcere femminile e il giorno dopo non è tornata alle due ore d’incontro. Abbiamo saputo che l’avevano pestata a sangue per quello che aveva detto. Dopo quest’esperienza preferirei fare lavorare i detenuti su un testo, un copione “neutro”, perché il rischio è che noi raccogliamo le loro denunce e ci sentiamo investiti di una grande responsabilità, ma loro pagano di persona la nostra mancanza di prudenza. Penaly
Reform International: www.penalreform.org
Un ex sindaco in cella si propone come collaboratore di “Ristretti” Giovanni
Antonino si era già occupato di carcere quando era primo cittadino di Brindisi.
Arrestato con l’accusa di estorsione, ha potuto guardare questo mondo
dall’interno scoprendone gli angoli più bui. Ora ha voglia di impegnarsi,
anche attraverso la nostra rivista, nell’attività di informazione “da
dentro” di
Marino Occhipinti “L’ex sindaco di Brindisi Giovanni Antonino, attualmente recluso, vorrebbe rendersi utile diventando un vostro referente dal carcere di Foggia e, una volta fuori, anche da Brindisi. Chiede di essere messo in contatto con un responsabile dell’associazione…”. Singolare e-mail, questa ricevuta poco tempo fa da Ornella Favero, la nostra coordinatrice. Affamati come siamo di corrispondenti da altri penitenziari, all’ex sindaco abbiamo subito risposto proponendogli di collaborare con noi, magari cominciando col descrivere la situazione del carcere dove si trova detenuto. Ma questa volta la giustizia è stata più veloce delle Poste Italiane, e Giovanni Antonino ha ricevuto gli arresti domiciliari prima della nostra lettera. È dunque con un po’ di ritardo che pubblichiamo la sua risposta: una testimonianza significativa perché proviene da chi, del carcere e delle sue problematiche, si era occupato già prima, quando era un amministratore pubblico. E sicuramente guardava a questo mondo parallelo con occhi diversi. Ho ricevuto solo oggi la vostra lettera e la rivista. Dal 18 febbraio, infatti, non sono più recluso nel carcere di Foggia in quanto, nel frattempo, il Tribunale del riesame di Lecce mi ha concesso gli arresti domiciliari. Per fortuna, sia pure con i tempi lunghissimi della burocrazia carceraria, la vostra busta mi è stata comunque recapitata. Innanzitutto ritengo urgente raccontarvi brevemente chi sono e come vi ho conosciuti. Fino all’ottobre dello scorso anno ho ricoperto la carica di sindaco di Brindisi, ruolo in cui ero stato confermato nel 2002 con il 73 per cento dei consensi. Sono stato arrestato in seguito alle dichiarazioni spontanee di alcuni imprenditori, a mio avviso tuttora prive di riscontri, i quali affermano di aver ricevuto da me richieste estorsive. Per poter affrontare al meglio e senza condizionamenti mediatici tali accuse (ma anche per allontanare il dubbio sulla possibilità di reiterare il reato o inquinare le prove), mi sono immediatamente dimesso. Ho scontato 133 giorni di custodia cautelare in carcere e ora sono agli arresti domiciliari, alle prese con una vicenda giudiziaria così intricata che a oggi, a indagine ancora in corso, consta di ben 17 mila pagine. Ma credo che la mia situazione giudiziaria vi interessi marginalmente. Più importante è forse evidenziare come in quattro mesi di detenzione ho girovagato fra tre diversi penitenziari (Regina Coeli a Roma, Brindisi e Foggia), entrando in contatto con un mondo fatto di abbandono, disperazione, assoluta mancanza di umanità, negazione organizzata di ogni forma di rispetto per la dignità umana. Da qui la mia volontà di impegnarmi per contribuire a cambiare un sistema che trovo aberrante, sia per le procedure che usa (la custodia cautelare come strumento di indagine; la difficoltà di accedere a forme alternative di detenzione; l’assoluta discrezionalità nella concessione dei benefici previsti dalla legge; l’assenza di programmi istituzionali di reinserimento), sia per gli aspetti che riguardano da vicino la vita carceraria (strutture vecchie, sovraffollamento, carenze nell’assistenza sanitaria, spazi di socialità esigui). Ho quindi chiesto ad alcuni amici di informarsi sulle associazioni che non si limitano all’assistenza dei detenuti – pure meritoria – ma cercano di presentare proposte concrete a quanti hanno responsabilità istituzionali, dando spazio e cittadinanza alle voci “da dentro”, creando occasioni di incontro, facendo controinformazione rispetto a un sistema che pare impermeabile a ogni novità. È così che sono arrivato a voi. Vorrei continuare questo impegno anche nella mia nuova situazione, mettendo a disposizione la mia esperienza di amministrazione di una città in cui il melting pot, così presente nelle carceri italiane, non è una novità. Una città in cui sono state avviate esperienze di reinserimento al lavoro attraverso società miste pubblico-privato e in cui, infine, si sono utilizzate le provvidenze previste dalle leggi 285 e 328 anche per attivare forme di sostegno alle famiglie dei detenuti, con assistenza domiciliare ai minori, centri di ascolto, strutture di intermediazione familiare. Nella convinzione che il “dopo carcere” sia il momento più difficile. Se una collaborazione “esterna” può comunque interessarvi, vi prego di farmelo sapere. Sto anche raccogliendo la mia esperienza in un libro-testimonianza che vorrei intitolare Frammenti di vita. Ho sottoscritto l’abbonamento alla rivista, che trovo veramente ottima. Spero di poter partecipare al convegno del 14 maggio “Carcere: L’alternativa che non c’è”, anche se non dipende solo da me. Sarebbe un’ottima occasione per scambiare opinioni e idee su una condizione, quella carceraria, che purtroppo non mi sembra abbia la priorità nell’agenda del governo e del Parlamento e, tanto meno, nei programmi delle diverse forze politiche. Giovanni
Antonino
Uno sguardo impetuoso di ragazza dentro
una distinta signora un po’ anziana Athe
Gracci, volontaria, ottantadue anni portati bene anche “grazie al carcere” di
Paolo Moresco “Molti amici mi chiedono se abbia mai timore nell’entrare in carcere e parlare con i miei detenuti. E io rispondo, sempre, che ci sono tante persone che ogni giorno affrontano l’ingresso di quei cancelli con il mio stesso slancio d’amore. Che a varcare quei cancelli, ogni volta, non provo alcuna apprensione: anzi, mi si apre il cuore”. Ottantadue anni portati benissimo (“uno sguardo impetuoso di ragazza dentro una distinta signora un po’ anziana”, così la dipinge Adriano Sofri, uno dei suoi “ragazzi” del carcere Don Bosco di Pisa), Athe Gracci è una professoressa di lettere in pensione, impegnata da sempre nel sociale, che per festeggiare i suoi cinquant’anni di volontariato ha recentemente pubblicato un libro, “I miei studenti reclusi”, in cui racconta con grande umanità e intelligenza la sua esperienza di animatrice culturale volontaria presso il carcere e il Centro accoglienza del Comune di Pisa. “Entrare in relazione con un detenuto o una detenuta, e iniziare con loro un percorso”, sostiene Athe, in un’affettuosa lettera che ha inviato alla nostra redazione, “non vuol dire minimizzare o addirittura rimuovere lo sbaglio che hanno commesso: la sfida non consiste insomma nel dimenticare, ma nel superare, nell’andare oltre. Sono esseri umani che bisogna conoscere e penetrare nella loro vita. Si scoprono così uomini e donne feriti e puniti dalla vita stessa. Ogni detenuto, come ogni essere umano, ha le sue debolezze, i suoi punti di rottura. Si tratta di rispettare in lui le sue zone d’ombra, di mistero, perché è indispensabile che certe cose restino segrete. Andare nel suo profondo per fare luce sul suo percorso. Bisogna aiutare il detenuto a ricostruirsi senza aver paura di affrontare la realtà. Credere in Dio è anche credere nell’uomo, perché chi crede sa ascoltare e capire gli uomini, i deboli e i reietti della sua epoca”. Quanto alla funzione di intermediario con il mondo esterno che il volontariato carcerario svolge, Athe la ritiene tanto importante che già si preoccupa per gli effetti negativi sulla vita dei detenuti che, fra qualche mese, avranno l’arrivo dell’estate e la conseguente, drastica riduzione delle attività trattamentali e della stessa presenza dei volontari negli istituti di pena. “D’estate la detenzione va a rilento”, spiega Athe. “Il detenuto non vede progredire il suo dossier, riceve meno posta e le attività socio-educative sono in gran parte sospese. Il tempo carcerario si dilata, le giornate finiscono per diventare insopportabilmente lunghe e tormentate, con il caldo che non dà requie e un accresciuto senso di distanza dal mondo esterno, che per definizione è ‘in vacanza’. Credo che sarebbe di grande importanza assicurare presenze extra in questo periodo, quando il senso di vuoto e di frustrazione rischia di angosciare più pesantemente i detenuti. Vorrei poter ridurre al minimo l’assenza delle persone volontarie in estate, cioè agevolarne la presenza, in modo da mantenere con i detenuti un legame sempre vitale ed essenziale per limitare le loro tensioni. Le Case di pena sono luoghi dove vivono uomini che la società ha punito, ma non per questo si deve cessare di nutrire speranza nei loro confronti. Non bisogna mai smettere di credere che, anche in carcere, sia possibile preparare uomini nuovi”. Dai suoi cinquant’anni di volontariato, dodici dei quali vissuti a quotidiano contatto con i suoi “ragazzi” del Don Bosco di Pisa, Athe Gracci ha tratto la convinzione che sia stato tempo ben speso, quello che ha vissuto per sua libera scelta dietro le sbarre. “Sono felice di poter testimoniare che il mio lavoro lo sento utile”, conclude infatti, “anche per la considerazione che queste persone mi rivolgono. Penso sovente a ciò che un giorno, in tempo di guerra, ebbi la fortuna di ascoltare da un personaggio di cui, dopo tanti anni, non ricordo più il nome: ‘Potremo sopportare la fame e la sete, ma non potremo sopportare l’indifferenza per questi uomini, forse colpevoli e spesso dimenticati”.
|