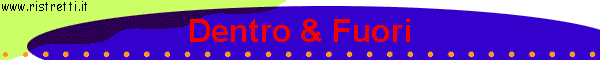
|
|
|
Non si può privare un detenuto del diritto all’istruzione
L’Università entra finalmente in un mondo in cui la grande maggioranza dei professori e degli studenti universitari non sono mai entrati
Intervista a cura di Marino Occhipinti
Dell’Università che entra in carcere abbiamo cominciato a parlare nell’ultimo numero di Ristretti Orizzonti e continuiamo ora con questa intervista al Professor Nedo Baracani, docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Ateneo di Firenze e delegato del rettore per il Polo Universitario Penitenziario toscano
Abbiamo deciso di approfondire la questione del Polo Universitario Penitenziario, perché sappiamo che anche a Padova si lavora per costruire un progetto analogo a quello fiorentino e riteniamo che sia utile "fare tesoro" delle esperienze degli altri, prima fra tutte quella toscana.
Professor Baracani, ci spiega quali motivazioni di base vi hanno portato ad impegnarvi nel progetto del Polo Universitario Penitenziario? Le motivazioni erano e sono molte. Per semplificare le riduco a quattro. La prima è legata alla necessità di praticare i diritti delle persone, pur con tutti i limiti che le situazioni impongono. Chi ha commesso un reato non perde i diritti della persona, e primo fra tutti la libertà di conseguire qualcosa che nella sua vita abbia per lui o per lei un senso. E lo studio e la formazione sono qualcosa che ha senso per le persone e le norme lo riconoscono come un diritto. Quello che manca è l’abitudine alla pratica dei diritti. La seconda motivazione è stata quella di mettere alla prova l’Università. Per sua natura, l’Università è un’istituzione antica e con ampia autonomia. La condizione posta era che il lavoro che avremmo svolto rientrasse nei compiti istituzionali dell’Università e come tale fosse riconosciuto dagli organi accademici. Questo per uscire da uno schema di volontariato che rimane certamente nella scelta soggettiva dei singoli che si impegnano, ma che deve trovare riconoscimento nelle istituzioni. Tanto il senato accademico, che, com’è noto, è formato dai presidi delle facoltà, quanto il consiglio di amministrazione hanno fatto questo passo, riconoscendo così gli studi dei detenuti come studi di normali studenti, certo con particolari condizioni e bisognosi di soluzioni adatte alla loro situazione. Si può legittimamente privare un detenuto di certi diritti (la libertà di movimento, l’accesso a certi ruoli sociali), ma non di quello all’istruzione, alla libertà di pensiero, di religione, e più in generale alla libertà di perseguire nella sua attuale condizione degli scopi per la sua vita. Ci è sembrato interessante ed importante verificare fino a che punto l’Università sarebbe riuscita, nel tempo, a misurarsi con questa situazione, dove è necessario per forza entrare in un mondo in cui la grande maggioranza dei professori universitari e degli studenti universitari non sono mai entrati. La terza motivazione riguarda il nostro ambiente sociale e culturale, la Toscana. Essendo già attive nelle carceri le scuole di base ed essendo attive sette scuole superiori (gli istituti sono 18 con circa 4.000 detenuti di cui circa 150 donne), si trattava di completare l’attivazione del sistema di istruzione, dandogli una base regionale nel senso di una rete di opportunità collegate con i tre atenei. L’ultima motivazione riguarda i legami che si devono incrementare tra le istituzioni e con il territorio, il che si traduce nell’accrescimento dei contatti tra il carcere e l’ambiente sociale: questi contatti possono assumere le forme più diverse, che è impossibile codificare a priori. Un insegnante, un professore universitario o dei giovani studenti che varcano la soglia del carcere non fanno solo un’esperienza per loro formativa (il contatto sostenuto dall’impegno delle istituzioni è la via migliore per combattere l’ignoranza, la separatezza, i pregiudizi). Lo stesso vale per il volontariato o per chiunque stabilisca una relazione. Per questa via il carcere diventerà sempre più parte del sistema sociale locale, sarà più conosciuto per via diretta, divenendo, per così dire, qualcosa di normale e, come tale, qualcosa di cui in futuro potremmo anche decidere di fare a meno, perché è nell’ispessimento delle relazioni sociali che nascono le idee per costruire e sperimentare delle alternative.
In concreto, in cosa consiste esattamente e come si sviluppa il vostro lavoro? In concreto il nostro lavoro consiste nel fare quello che facciamo sempre, seguire gli studi di un certo numero di studenti: questi però sono in carcere e sono diversi per età, per vissuti personali, per lunghezza della pena, per condizione di detenzione, per corso di studi prescelto. È una cosa terribilmente complicata, perché abbiamo voluto mantenere il più possibile la libertà di scegliere qualunque percorso, affrontando i problemi del numero programmato, sia in sede locale che in sede ministeriale. Nell’estate di ogni anno viene fatta una ricognizione negli istituti toscani per raccogliere le intenzioni di iscrizione. Noi cerchiamo poi, anche se non sempre ci riusciamo, di rispettare la procedura di lavoro che ci siamo data e che prevede che, prima dell’iscrizione, ci sia un colloquio di carattere generale ed uno specificamente orientato sulla scelta che lo studente ha ipotizzato. C’è poi la questione dell’Alta Sorveglianza, con un regime carcerario particolarmente vincolante, dove abbiamo 12 iscritti e dove dobbiamo ancora realizzare le condizioni che piano piano si sono create nella sezione di media sicurezza. Si tratta, in sostanza, di poter lavorare su orari abbastanza lunghi (in media sicurezza si è concordata un’apertura dalle 8 del mattino fino alle 18.50 del pomeriggio) e di poter contare su spazi e attrezzature sufficienti. In Alta Sorveglianza le cose sono più complicate, e ci sono anche maggiori difficoltà per gli strumenti di studio. C’è inoltre la questione dell’area penale esterna che comprende oggi 8 detenuti in condizioni molto diverse l’uno dall’altro.
Cosa succede quando un detenuto studente del Polo Universitario Penitenziario ottiene una misura alternativa alla detenzione oppure termina la pena, e quindi esce dal carcere? Chi esce in misure alternative rimane inserito nel progetto con i benefici che comporta, mentre chi esce per fine pena rimane iscritto per un anno e poi la sua situazione deve essere riconsiderata. Le storie personali, però, sono le più diverse, chi esce in semilibertà non necessariamente rimane in Toscana, e quindi vengono meno le condizioni per un qualunque lavoro. Infine, chi esce in semilibertà, dovendo lavorare, si trova immediatamente in una situazione difficile. Ci vorrà molto tempo per comprendere fino in fondo quali soluzioni siano da adottare di fronte a queste situazioni. Questo ci dice che abbiamo già le nostre perdite, né più e né meno di quanto avviene normalmente all’Università, anche se qui per ragioni ed in condizioni molto diverse. Per tutti, e con modalità diverse, dovremmo riuscire a realizzare regolarità negli incontri con i docenti, costanza dell’azione dei tutor, supporto per la didattica, sostegno in situazioni di difficoltà. Non ci vuole molto a comprendere quanto sia difficile, anche dal punto di vista organizzativo, tener presenti tutte queste situazioni. Ci sono state, quest’anno, anche circa 30 richieste di detenuti provenienti da altre regioni, che non possiamo accogliere e che forse è giusto non accogliere, a meno che, concordandolo, non vengano trasferiti in un istituto della Toscana, perché pensiamo che, in linea generale, una rete di opportunità debba essere costruita in tutto il paese per iniziativa delle istituzioni universitarie, delle Regioni e dell’Amministrazione, essendo questa una responsabilità collettiva.
Quante persone sono coinvolte nell’iniziativa, detenuti ma anche docenti e collaboratori? Ci sono, innanzitutto, i 54 studenti iscritti alle diverse facoltà, in condizioni molto disomogenee. Il gruppo che si trova nelle condizioni migliori è quello della sezione ottava di media sicurezza, uno spazio appositamente destinato a studenti universitari, con 22 celle singole ed una sala di studio, oltre ad una cella adibita ai colloqui con i docenti con un computer abilitato (con precisi vincoli) alla comunicazione con l’esterno. Fra qualche settimana attiveremo una esperienza di teledidattica: si tratta di un meccanismo preparato dai nostri colleghi di ingegneria, approvato dal Ministero ai fini della sicurezza delle comunicazioni, e che si spera di poter attivare in parallelo col funzionamento della pagina web sul sito della nostra università. Le persone coinvolte nell’iniziativa sono tante e, anche qui, il problema principale è quello di mantenere attive le relazioni tra di loro, senza di che viene meno il senso del lavoro collettivo (su questo punto c’è molto da fare). Un ruolo fondamentale hanno i delegati di facoltà e tutti i colleghi delle varie discipline che vengono attivati per definire programmi e preparare gli studenti agli esami: il loro lavoro può contare su dei tutor che, su un programma concordato, svolgono attività di sostegno alla preparazione. Dei volontari mantengono contatti regolari, danno la loro disponibilità in momenti di difficoltà, si occupano delle necessità collegate con la didattica, realizzano attività culturali e, da quest’anno, si spera possano anche svolgere un compito didattico nel campo della formazione di base (ci sono detenuti che riprendono gli studi dopo un periodo anche lungo, e che quindi hanno necessità di riacquisire confidenza con lo studio, con il suo linguaggio o con un computer - questo è uno dei progetti sui quali abbiamo chiesto risorse per il 2003). Fra le persone coinvolte ci sono anche tutti quegli operatori che rendono possibile il funzionamento dell’intero marchingegno, da quelli interni all’Università, che hanno la pazienza di esaminare queste situazioni sovente complicate, a quelli interni all’Amministrazione Penitenziaria. Tutto questo lavoro non potrebbe funzionare se non ci fosse l’attività di volontariato, in particolare dell’Associazione del Volontariato Penitenziario e l’Associazione L’altro Diritto. La loro presenza è costante e diversa dalla nostra e dunque, pur collaborando con noi, hanno una loro precisa identità, e gli studenti lo capiscono bene.
Quali sono invece le difficoltà che avete incontrato e, soprattutto, come siete riusciti ad affrontarle e superarle? Le difficoltà sono molte e non c’è spazio in un’intervista per analizzarle, e dunque mi limito a segnalarle senza particolari approfondimenti. A parte il "superamento" della soglia del carcere come confine fisico e psicologico (la maggioranza dei colleghi non l’aveva mai superata per sua scelta), i problemi sono quelli della ridefinizione del tempo (i parametri sono diversi, diverso è il tempo di vita della giornata e diversi sono i tempi dell’apprendimento), del tracciare un percorso di studio, della comprensione di che cosa significa per la persona quella scelta di studio e quindi dell’orientamento su quella scelta, del superamento delle crisi che sono inevitabili, dell’accettazione delle difficoltà di relazione (soprattutto nella struttura penitenziaria, per ragioni che attengono solo in parte ai comportamenti delle persone), dell’osservanza delle procedure. Queste non sono difficoltà che si "superano": si impara a riconoscerle e a costruire delle soluzioni facendo appello alle nostre risorse personali e di comunicazione con gli altri. Ognuno dei punti richiamati è un titolo da sviluppare e da approfondire. Credo però che questo semplice elenco sia sufficiente per far comprendere che i veri ostacoli sono di tipo comunicativo (capire che cosa una persona sta perseguendo, concordare con qualcuno qualcosa che non era previsto, adattarci noi a delle procedure senza rifiutarle per poter chiedere agli altri un adattamento che, magari, richiede un impegno particolare, comprendere che molte piccole cose assumono in quel contesto una rilevanza per noi nuova, lavorare per il superamento reciproco di stereotipi, cominciare a fidarsi reciprocamente). Sottolineo questo tipo di questioni anche perché fra le difficoltà vanno certamente annoverate quelle con il personale del carcere. Soltanto quest’anno è stato possibile iniziare un discorso diretto, perché per un lungo periodo c’è stato un atteggiamento di non accettazione della scelta che era stata fatta con questo progetto. Può sembrare un tempo molto lungo, ma non so se sia così. Credo invece che dobbiamo rispondere alle obiezioni che vengono mosse, anche a quelle che fanno perno sulla iniquità di offrire a delinquenti opportunità che molte persone perbene non hanno. Se troveremo un punto d’intesa su questioni simili, la strada sarà aperta a molte esperienze interessanti. Personalmente ritengo che queste posizioni siano il frutto di una comunicazione mancata, anche da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, e che le persone che riconoscono non solo la legittimità, ma anche la necessità di questi programmi siano molte di più di quanto non dicano loro stesse.
Vorremmo conoscere più dettagliatamente i particolari legati agli aspetti istituzionali: siete riusciti a stipulare convenzioni, protocolli d’intesa, così da coinvolgere quanto più possibile altri enti e realtà? Il più importante aspetto istituzionale riguarda gli studenti e il lavoro dei docenti, dal momento che gli accordi di collaborazione sono importantissimi, ma prima di tutto era importante che l’Università riconoscesse il lavoro del suo personale come lavoro normale, istituzionale, appunto; allo stesso tempo era importante che riconoscesse quegli studenti esattamente come gli altri, anzi, come un gruppo svantaggiato. La nostra presenza in carcere è dunque diversa da quella dei volontari, e questo spiega anche il maggiore impatto reciproco tra università ed ambiente penitenziario. Fare di questo progetto qualcosa di istituzionale significherà, in futuro, che studenti universitari potranno avere dei contatti con la realtà penitenziaria: penso a studenti dell’area psicologica, biomedica, educativa, del servizio sociale che potranno svolgere esperienze di tirocinio, preparare elaborati, condurre ricerche. Mi aspetto, gradualmente, un "ritorno" sull’Università attraverso le esperienze di docenti e studenti. Gli accordi e i protocolli nascono quando si sviluppano delle strategie di comunicazione e di collaborazione: essi sono, in genere, un punto di arrivo di qualcosa che matura e l’apertura di possibilità che si costruiscono e si ampliano nel tempo, sempre che si riesca ad instaurare quella comunicazione basata sul reciproco riconoscimento di cui prima accennavo.
Il diritto allo studio dei detenuti viene garantito anche dal punto di vista economico? L’avvio del progetto, proprio per l’impegno istituzionale e per le motivazioni ricordate, ha portato anche l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella sua articolazione sui tre atenei, a decidere quest’anno l’inserimento di questi studenti nel bando per le borse di studio, seguendo i criteri già stabiliti per un altro gruppo di studenti svantaggiati, i portatori di handicap, il che significa allungare i tempi degli studi e determinare una soglia di crediti più bassa ai fini dell’ottenimento di una borsa di studio. Questo ha fatto sì che dieci studenti abbiano potuto presentare la domanda e che, c’è da sperarlo, una parte almeno di loro, la possano ottenere. L’Università, per suo conto, ha ridotto le tasse di iscrizione alla sola "quota statale" (110 euro), quota che chi può se la paga e chi non può viene sostenuto dal volontariato attraverso i fondi esterni. I diritti costano e ci sono anche molte persone che pensano che consentire questo a dei carcerati sarebbe iniquo, perché prima dovremmo occuparci di tutti gli altri. In linea generale, però, io sono convinto che non sono mai i soldi che mancano, essendo più difficile elaborare idee e progetti, saper spendere in modo efficace, mobilitare le persone con le loro risorse, essere capaci di riflettere continuamente su ciò che facciamo.
In quinta elementare un maestro mi ha detto "Tu farai una brutta fine"
Dal carcere di Rovereto, una inchiesta "illuminante" sul "passato scolastico" di molti studenti-detenuti
Un’insegnante del carcere di Rovereto, Gianna Mantovani, ha curato una "illuminante" inchiesta sul "passato scolastico" dei suoi studenti-detenuti, che poi è stata pubblicata su "DENTRO", il periodico della Casa Circondariale di Rovereto, con un titolo che è una frase di don Lorenzo Milani: "La scuola ha un solo problema: i ragazzi che perde". Sarebbe utile che anche gli insegnanti che insegnano nelle scuole "normali" leggessero alcune di queste testimonianze, per riflettere su quello che la scuola troppe volte non fa: dare un’attenzione vera alle persone e cercare di non lasciare per strada i ragazzi che faticano a stare al passo con i bravi, gli inseriti, gli "inclusi".
La Redazione
Ho frequentato la scuola elementare e media in diversi collegi. In uno di questi ho incominciato a rubare. A scuola non ero fra i peggiori, avrei voluto continuare a studiare ma non c’erano collegi che potessero accogliermi dopo i quindici anni, così a quindici anni e mezzo sono finito in riformatorio. Ero un ragazzo molto vivace e lì dentro ho imparato molte cose, ho conosciuto molte persone con i miei stessi disagi ed ho capito che l’unica strada che potevo percorrere era fare il delinquente. Non ricordo la scuola del riformatorio, evidentemente poco visibile, poco efficace. Adesso sono qui, in carcere, frequento la scuola ma credo sia tardi per recuperare gli anni perduti ed il mio sogno di fare l’architetto rimarrà sempre solo un sogno.
Gaetano
Io sono andato a scuola un anno dopo. Ho ripetuto due anni alle elementari e non volevo andare alle medie perché non mi piaceva studiare; a scuola andavo male, ero un bambino timido e pauroso e vigliacco. I miei compagni mi facevano dispetti, mi rincorrevano e mi strappavano il grembiule così quando arrivavo a scuola me le sentivo dall’insegnante. Mia mamma mi difendeva ma gli insegnanti mi sgridavano lo stesso. Io a scuola avevo paura come ora nella vita.
Oscar
All’inizio ho vissuto la scuola come un’avventura; gli insegnanti erano dei "generali" piuttosto maneschi: lì si doveva obbedire, c’era più la disciplina che l’imparare. Gli insegnanti erano attenti più al loro ruolo di direttori che a quello di chi deve insegnarti ad imparare. In quinta elementare un maestro mi ha detto: "Tu farai una brutta fine". A quel tempo finii in collegio per questioni familiari ed il mio rapporto con la scuola peggiorò ulteriormente. Non ho bei ricordi della scuola.
Giulio
Ricordo i primi anni di scuola come un esilio. Ricordo il distacco da mia madre. Delle elementari ho ricordi abbastanza belli, la maestra era gentile, poi più avanti, col passare degli anni, ho avuto difficoltà nello studio, ero distratto, non mi interessava stare a scuola, i miei veri interessi erano al di fuori di essa e cominciai a trasgredire, le compagnie mi attiravano di più che l’aver successo a scuola. Mi sono sentito il "bulletto", il leader del gruppo, quello che non aveva più niente da imparare nella scuola e tutto quello che si faceva lì dentro era mortalmente noioso: in classe nessuno mi faceva sentire importante come nel gruppo.
Gianni
La scuola di quando ero piccolo era una scuola sbagliata. Io ero un bambino molto vivace ed aggressivo e gli insegnanti credevano fosse facile domarmi. Io ero più forte di loro, facevano i duri con me ma io ero più duro di loro, per loro le cose che facevo erano tutte sbagliate ed io ero già segnato, da me si aspettavano solo trasgressione e non ho ricordi di qualcuno che mi abbia detto "bravo" una sola volta. Possibile che fossi un tale disastro sempre e comunque? Ogni tanto mi viene il dubbio che se in quei primi anni avessi trovato anziché un collegio e degli insegnanti che pensavano solo a difendersi, delle persone sensibili, coscienti di quanto stava succedendo in me, forse la mia storia sarebbe stata diversa… o forse no!
Massimiliano
Io sono vecchio, non ricordo quasi nulla della scuola che ho frequentato per circa sei mesi e dalla quale sono stato buttato fuori per essere inserito in una scuola differenziale (esistevano più di trent’anni fa). Lì ho resistito per circa un mese e ricordo maestri maneschi, violenti, molto autoritari e rigidi. Risultato: me ne sono andato per entrare nella scuola della vita. La scuola di oggi è diversa, gli insegnanti sono più comprensivi e consapevoli che il pugno duro e l’autoritarismo non servono ad avvicinare gli alunni al conoscere, al sapere, mentre l’essere più vicini a loro aiuta a formare la loro personalità.
Lorenzo
La scuola per me è stata una fatica; cinque anni di medie e non ho conseguito il diploma! Era una costrizione anche se mi sarebbe piaciuto imparare, ma il mio corpo si ribellava e finivo sempre per essere sbattuto fuori. Peccato perché l’apprendere ed il conoscere è stato per me sempre un piacere; non so cos’è che non ha funzionato ma a scuola ero un ribelle e forse è stato lì che ha avuto inizio la mia trasgressione. Oggi trovo questa scuola più adatta a me e, ironia della sorte, qui in carcere meno costrittiva di quella fuori. Ma forse perché sono diventato più grande e più consapevole.
Salvatore
Sono andato a scuola ed ho frequentato per tanti anni ma non ho mai conseguito alcun diploma, nemmeno la licenza elementare. Ero in collegio e trovavo la scuola noiosa, faticosa, un obbligo tremendo, non riuscivo a farmela piacere. In collegio mi mettevano a fare le pulizie, a curare i fiori, così non ho mai imparato a leggere e scrivere bene. Oggi frequento la scuola sperando di colmare le lacune del passato. Qui a scuola ho imparato che si può stare bene perché non c’è competizione né obblighi particolari e quello che faccio lo faccio per me.
Ivan
Ricordo la scuola S. Lucia come una scuola che ho vissuto non bene, con conflitti con tutti i maestri. Il primo giorno in terza elementare sono stato sospeso per cinque giorni per aver rotto un vetro con un sasso. Ho fatto due volte la terza media, due volte la prima geometri, due volte il corso superiore di radiologia. Non ho avuto grandi rapporti con gli insegnanti, ero taciturno e menefreghista, mi creavo una barriera per difendermi però non ero aggressivo, non rispondevo e davo l’impressione di essere apatico e svogliato. Non ricordo insegnanti che mi abbiano stimolato o aiutato; venivo vissuto come l’antipatico e tutto finiva lì.
Lanfranco
Io sono Sinto e l’andare a scuola significava incontrare amici ed insegnanti. Ricordo insegnanti abbastanza bravi che con pazienza mi facevano scrivere, leggere e giocare a tombola. Non ho ricordi particolarmente brutti della scuola, anche se spesso si distribuivano, insieme ai premi, delle sberle… ma solo quando era necessario. E questo valeva per tutti, non solo per me. La mia attività scolastica si è conclusa dopo le prime tre classi elementari.
Federico
La scuola, quando ero piccolo, non mi piaceva; ero molto ribelle, molto giocherellone e non trovavo alcun interesse a seguire le lezioni che mi sembravano lunghe e noiose. Ho cercato di fare qualcosa per poter avere un diploma; ho fatto le elementari, due volte la prima media senza concludere, sono andato a fare un corso di elettricista e poi di radiotecnico, ma anche qui ho lasciato al secondo anno; la mia volontà di studiare è stata sempre debole, non per colpa dei professori ma per il mio rifiuto così come non riesco a leggere un libro che abbandono, dopo averlo cominciato, come se sapessi già come finisce. Adesso sono stato io a scegliere di fare dei corsi perché qui in carcere non c’è nulla da fare, per riempire le giornate e fare qualcosa di diverso. E se riesco ad avere il diploma, mi servirà per poter far valere il corso di elettricista, l’unico che sono riuscito a fare. Quasi tutti gli anni di scuola fatti li ho frequentati in giro per mezza Italia a causa della mia malattia.
Claudio
|