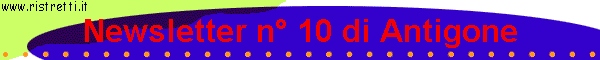
|
|
|
Newsletter numero 10 dell'Associazione "Antigone" a cura di Nunzia Bossa e Patrizio Gonnella
Diritti umani senza giustizia, di Patrizio Gonnella
Nelle ultime settimane le vicende delle torture inflitte dai militari statunitensi nei confronti dei combattenti iracheni hanno riproposto pubblicamente la questione della effettività dell’apparato internazionale, giurisdizionale e non, posto a tutela dei diritti umani. Nel luglio del 1998 proprio a Roma veniva solennemente firmato lo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale (ICC) che avrebbe dovuto giudicare tutti coloro, in giro per il mondo, che si sarebbero resi responsabili di crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio. Oggi la Corte è attiva, ha un Procuratore generale al lavoro (di nazionalità argentina), ha un Presidente e una Camera composta da diciotto giudici eletti dall’Assemblea degli Stati parte. Gli Stati che hanno ratificato lo Statuto, e per i quali funziona la Corte quale giudice sopranazionale, sono alla data odierna ben 94, di cui 24 africani, 11 asiatici, 41 europei e 18 latinoamericani. Fra questi non c’è Cuba, non c’è la Cina, non c’è la Russia, non c’è l’Iraq, non ci sono gli Stati Uniti di America. Gli Stati Uniti, all’epoca di Clinton, avevano firmato lo Statuto – ma non ratificato – al solo scopo di partecipare ai lavori preparatori e condizionare i contenuti delle regole di procedura. Una volta nata la Corte, questa volta con Bush presidente, gli Usa hanno ritirato la firma. Ma non si sono limitati a questo. Hanno iniziato una vera e propria attività di lobby nelle Nazioni Unite e con gli Stati alleati per depotenziare gli effetti di controllo giurisdizionale della Corte dell’Aja e impedirne la giurisdizione nei confronti dei soldati americani impegnati nei più disparati fronti bellici. Infatti, seppur non firmatari dello Statuto di Roma, gli Stati Uniti avrebbero comunque rischiato di vedere i propri militari incriminati, in quanto se il crimine da questi ultimi fosse stato compiuto nel territorio di uno Stato firmatario, comunque lo Stato avrebbe dovuto giudicare il soldato americano o consegnarlo ai giudici dell’ICC. Le manovre diplomatiche americane si sono quindi mosse in due direzioni. Da una parte nei confronti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ottenendo due risoluzioni consecutive nelle quali si prevedeva che non ci sarebbe mai stata giurisdizione della Corte nel caso di militari impegnati in operazioni di peace-keeping, anche qualora i fatti fossero stati commessi in territori appartenenti a Stati che avevano aderito alla Corte stessa. Dall’altra parte l’azione diplomatica si è diretta nei confronti di singoli Stati firmatari dello Statuto. Con questi ultimi gli Usa hanno firmato decine e decine di accordi bilaterali diretti a non perseguire, e quindi punire, cittadini americani presenti in quel territorio. Ad esempio l’Afghanistan di Karzai ha firmato questo accordo, pertanto ai militari statunitensi viene assicurata l’assoluta impunità. L’Iraq al tempo di Saddam non aveva ratificato lo Statuto, pertanto anche lì i militari americani possono torturare, come hanno d’altronde fatto, senza rischiare di essere sottoposti alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Eppure la Corte, nonostante boicottaggi, silenzi e tentativi di affossamento, ha iniziato a funzionare. Fra le ultime inchieste attivate dal procuratore Luis Ocampo vi è quella relativa ai crimini contro l’umanità commessi in Uganda, nel campo di prigionia di Barlonya, nel febbraio del 2004, quando oltre duecento persone sono state ammazzate a sangue freddo. L’accusa è di genocidio. Quando si parla di diritti umani la geografia dei Paesi che si oppongono al rafforzamento degli organismi di tutela sopranazionale è più o meno sempre la stessa. Stati Uniti, Cuba e Cina si sono ritrovate insieme nell’ostacolare la moratoria universale della pena di morte in discussione presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e sono fra i paesi che non hanno né firmato né ratificato il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura. Questo, per entrare in vigore, richiede almeno venti ratifiche; al momento sono solo tre (Albania, Malta e Regno Unito). Esso prevede un meccanismo universale di ispezione di tutti i luoghi di detenzione, Guantanamo e Abu Ghraib comprese. Si applica ai soli Stati aderenti. E gli Usa, Cuba e l’Iraq non sono fra questi. L’Italia lo ha firmato lo scorso 20 agosto, ma non lo ha ancora ratificato. Su sollecitazione dell’associazione Antigone, nei giorni scorsi, 45 senatori- prima firmataria Tana De Zulueta – hanno depositato un disegno di legge di ratifica del protocollo. L’Italia ha una buona consuetudine nell’aderire ai trattati internazionali. Non altrettanto velocemente adatta l’ordinamento interno ai dettami delle norme internazionali recepite. Ad esempio il nostro codice di procedura penale non è stato ancora modificato e non vi è traccia in esso della giurisdizione concorrente della Corte Penale Internazionale. Così nel nostro codice penale non vi è ancora il delitto di tortura, nonostante esso sia fra i crimini che ricadono sotto la giurisdizione dell’ICC e nonostante una apposita Convenzione Onu lo imponesse dal lontano 1984. Negli scorsi mesi il disegno di legge che introduceva il reato di tortura nel nostro ordinamento penale è stato impallinato alla Camera da alcuni emendamenti, in particolare uno della leghista Lussana che prevedeva la perseguibilità del torturatore solo se recidivo. Dopo giorni di polemiche veementi e l’indignazione di associazioni attive nel campo dei diritti umani, fra cui Amnesty International, la proposta di legge è tornata in Commissione Giustizia per un ulteriore riesame ed è oggi nuovamente all’ordine del giorno dei lavori. Il prossimo 26 giugno è la giornata mondiale dell’Onu contro la tortura, chissà se per quel tempo l’Italia avrà onorato i suoi impegni internazionali e il Protocollo avrà raggiunto il numero di adesioni utili a funzionare. L’attualità ci dimostra che la tortura non è un crimine del passato e che di controllori e giudici in giro per il mondo c’è proprio bisogno.
*L'articolo è tratto da Italia Oggi del 27/5/04
Osservatorio parlamentare, a cura di Francesca D’Elia
Primo via libera al mandato d’arresto europeo
In data 12 maggio, l’Aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento che recepisce nell'ordinamento italiano il mandato d'arresto europeo, quindi passato all’esame del Senato. Alla versione originaria del testo sono state apportate importanti modifiche per tentare di conciliare le esigenze derivanti dalla costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza tra i paesi dell’Unione Europea e la nostra Costituzione. Intanto, la richiesta di arresto potrà essere accolta in Italia soltanto se il Paese che la avanza ha nella sua Carta Costituzionale il richiamo ai principi del giusto processo contenuti nella nostra Costituzione e rispetta la Convenzione per i diritti umani. Quale autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti, viene designato il Ministero della Giustizia, al quale spetta la trasmissione e la ricezione dei mandati e tutta la corrispondenza relativa (sarà, però, possibile per le singole autorità giudiziarie avere contatti e colloqui diretti tra loro, senza la continua intermediazione del Ministero). E ancora: un Paese straniero per ottenere il mandato d'arresto dovrà fornire più di una trentina di documenti. Vi sarà il raddoppio delle procedure burocratiche rispetto all'estradizione, dovendo, infatti, il giudice straniero allegare tutti quei documenti che provino che non ci sono le condizioni per rifiutare la richiesta: dalla descrizione delle circostanze della commissione del reato, alla relazione sui fatti addebitati con tanto di indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo dove questo è stato commesso. Nel caso manchi qualcosa, il Ministero dovrà farlo presente al Paese richiedente che dovrà quindi provvedere a colmare la lacuna, pena il rigetto della domanda. Il mandato d'arresto europeo dovrà essere trasmesso in Italia tradotto nella nostra lingua e l’ ignorantia legis si potrà accettare solo dal cittadino italiano e non dagli stranieri. Nel caso in cui un Paese Ue chiederà al nostro Paese di eseguire un mandato di arresto, questo dovrà provare solo che esiste il pericolo di fuga del ricercato e non anche che ci siano le esigenze cautelari. Il mandato d'arresto perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non arriva entro i 90 giorni dalla sua esecuzione. Vi sono, poi, 32 casi in cui si dovrà dare esecuzione al mandato d'arresto indipendentemente dalla doppia incriminazione. Tra questi: il traffico o il commercio di droga e armi, anche armi nucleari, l'omicidio, i reati ambientali, la falsificazione di denaro, etc. La polizia, oltre a mettere in esecuzione il mandato d'arresto, nel caso di fermo di una persona che risulti ricercata nel “Sistema d'informazione Schengen”, può procedere all'arresto che dovrà comunque essere convalidato dal magistrato che ne dovrà essere informato entro le 48 ore. In alcuni casi la Corte d'Appello potrà rifiutare la consegna (come ad es. nell’ipotesi che il reato in Italia sia già prescritto, oppure se la persona per la quale si chiede l'arresto gode nel nostro paese di immunità, o se è già stata pronunciata in Italia la sentenza di non luogo a procedere). Contro i provvedimenti che decidono la consegna di una persona è possibile proporre il ricorso per Cassazione entro 10 giorni dal quello dell’informazione sul fatto.
Audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sanità penitenziaria
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sanità penitenziaria, in data 4 maggio, sono stati ascoltati i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato che operano nel settore: Antigone, la Lega italiana per la lotta all'Aids, A Roma insieme, La Fraternità e la Conferenza nazionale volontariato giustizia. Dal 2001 al 2003, e dunque in un periodo di soli due anni, oltre 500 sarebbero stati i detenuti morti nelle carceri italiane per “malasanità“ o per suicidio: in media uno ogni due giorni, e circa la metà di età inferiore ai 40 anni. Questo il dato diffuso da Livio Ferrari (Conferenza nazionale volontariato giustizia), rispetto al quale Antigone (rappresentata da Patrizio Gonnella e Francesca D’Elia) ha anche precisato che i suicidi sarebbero stati 65 (57 per l' Amministrazione penitenziaria), tra i quali due minorenni. Circa 17 mila detenuti risultano tossicodipendenti, diecimila hanno forme di disagio mentale, altri diecimila sono colpiti da malattie infettive (soprattutto epatiti), mentre tornano a colpire scabbia, tubercolosi e sifilide, tutte malattie che sembravano ormai appartenere al passato. Nel documento consegnato ai deputati, Antigone ha poi ricordato i risultati di una recente ricerca finanziata dall' Istituto superiore di Sanità su 175 operatori sanitari (dei quali 103 medici) di Istituti di pena in sette regioni, dalla quale è emerso che, ad esempio, il 72,3% degli intervistati ritiene insufficiente o largamente insufficiente il budget destinato dal suo Istituto alla sanità; che nella metà delle carceri all' ingresso non viene consegnato alcun materiale informativo di carattere sanitario, e che solo nel 27,7% degli istituti si consegnano opuscoli di educazione sanitaria. Inoltre, in meno della metà degli istituti c’è una guardia medica per tutte le 24 ore; in un solo istituto su quattro è presente un defibrillatore, e in più della metà ci vogliono almeno 12 ore per avere i medicinali di base. Nonostante, poi, la metà dei medici ritenga che in carcere vi sia un rischio medio-alto di contrarre l'epatite B e la probabilità, per un terzo di loro, di contrarre l'Hiv/Aids in carcere, negli ultimi tre anni quasi il 60% degli Istituti non ha predisposto alcuna iniziativa di prevenzione specifica. E tutto ciò in un quadro nel quale il ministero della Giustizia ha progressivamente ridotto i fondi per la sanità penitenziaria: 16 milioni di Euro in meno nel 2003 (pari al 30% dello stanziamento per il 2002, già ridotto del 20% rispetto al 2001). Le Associazioni chiamate in audizione hanno anche sottolineato che le Sezioni a custodia attenuata (previste dal Testo Unico sulle tossicodipendenze del '90) ospitano solo il 14% dei detenuti tossicodipendenti, e che soltanto in pochi Istituti di pena è stato attivato il “Presidio nuovi giunti” che dovrebbe fornire un primo sostegno alle persone appena arrestate (quelle tra le quali si verificano più frequentemente suicidi e atti di autolesionismo). Risulterebbe anche che nelle carceri i dispensari farmaceutici non sarebbero adeguatamente aggiornati e i medicinali sarebbero quelli della generazione precedente agli ultimi ritrovati. Rispetto, poi, al trasferimento delle competenze della medicina penitenziaria dal ministero della Giustizia a quello della Salute, previsto dal decreto legislativo 230/99, l’attuazione -a parere delle associazioni- risulterebbe praticamente solo sulla carta.
Jimmi della collina di Massimo Carlotto, di Tilde Napoleone
“Questo libro è dedicato ai volontari dell’associazione Oltre le sbarre di Cagliari e a don Ettore Cannavera della comunità La Collina di Serdiana”, è dedicato al loro “straordinario lavoro” che consente di sostenere i percorsi di vita di ragazzi come Jimmy. Jimmy è un duro, un “ragazzo difficile”, che nonostante provenga da una famiglia “normale”, decide di dedicarsi ai furti, alle rapine, ma non per vizio, solo perché vuole mettere i soldi da parte per costruire il suo futuro. Per lui il crimine è una scorciatoia, l’unico modo possibile per accumulare un bel gruzzoletto da investire. Ascoltare le sue parole, entrare nei suoi pensieri ce lo fa sentire più vicino. Per questo è importante che il libro faccia parte di una collana per ragazzi. Jimmy non è diverso dagli altri ragazzi che come lui sognano una quotidianità migliore. Il grosso colpo, quello che gli avrebbe dato la libertà, lo consegna invece alla galera. Per la prima volta dentro, incontra il mondo dei più duri e si adegua. I colloqui con le figure istituzionali del carcere, fanno solo da sfondo alle vicende che per Jimmy sono davvero formative: i rapporti di forza con gli altri ragazzi, i tradimenti, il dover essere qualcuno, la necessità di farsi un nome, il dover nascondere fragilità e debolezze. Quei colloqui con l’educatore, il direttore, lo psicologo, risuonano paradossali. A Jimmy sono richieste cose impossibili; nessun dialogo è sincero. Le chiusure da entrambi i lati non lo permettono. Il carcere è questo; non promuove cambiamenti, non può farlo perché fonda la sua esistenza sulla falsità. Jimmy capisce che deve far finta di…sempre, con l’istituzione e con gli altri ragazzi. Alla fine capisce che deve far finta di essere cambiato perché questo lo aiuta nei suoi piani di fuga. Ma ad un certo punto la barriera viene rotta e solo grazie all’esterno, alla comunità esterna che entra in carcere per proporre relazioni significative, che non siano strumentali a qualsivoglia obiettivo. Un gruppo di volontari, persone che non giudicano, che non chiedono, che non controllano, permettono quasi in modo naturale a Jimmy di rivedere la propria esperienza e di valorizzare un altro modo di comunicare. Se il carcere ancora deve esistere (arriveremo un giorno al suo superamento?), non può farlo se non in costante comunicazione e scambio con l’esterno; un esterno che però sia davvero significativo, accogliente, favorevole all’ascolto. L’esperienza di don Ettore Cannavera ci dimostra che qualcosa di diverso in questo senso è possibile. Il suo sforzo costante di mettere in relazione, di rendere la comunità, i cittadini tutti, soprattutto quelli che hanno maggiori mezzi, responsabili in prima persona del tentativo di includere ragazzi che sono stati esclusi, è un esempio da seguire e possibilmente da moltiplicare.
Carcere: l'alternativa che non c'è, di Tilde Napoleone
Ancora una volta il gruppo Ristretti di Padova organizza una giornata di studi e di approfondimento dentro le mura carcerarie. Lo scenario è quello consueto, tranne alcune modifiche, e in quanto tale è degno di attenzione e ammirazione. Al di là di ogni retorica e di ogni sentimento buonista, vedere mischiati detenuti, magistrati, gente comune, volontari, poliziotti penitenziari, istituzioni, all’interno di un carcere, desta ogni volta sconcerto e piacere insieme. Finalmente si realizza l’idea di società che molti di noi conservano gelosamente; per un attimo, anzi per una giornata intera, i ruoli scompaiono in una discussione che accomuna tutti i presenti: le misure alternative, come fare per renderle una reale alternativa al carcere e non una forma di controllo in più. Le misure alternative, allo stato attuale, sono infatti l’unico strumento di punizione di cui disponiamo per allontanare il carcere dalle nostre prospettive e dai nostri incubi; nonostante ciò, esse non sono ancora l’alternativa alla detenzione. I tassi di carcerazione, infatti, non sono diminuiti con il crescere della loro applicazione. La discussione, nel convegno padovano organizzato da Ristretti e dalla Conferenza nazionale volontariato giustizia, si è incentrata sul perché di tanta disattenzione e sui modi per migliorare un sistema che non avanza. Sono tanti gli interventi susseguitisi, forse troppi per i tempi contingentati di quello che è comunque e sempre un carcere. Significativo, tra gli altri, l’intervento di Alessandro Margara, presidente della Fondazione Michelucci nonché ex magistrato di sorveglianza ed ex capo del Dap, perché illustrativo di una proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo impianto generale. La sua è una provocazione; Margara stesso infatti ammette che in questo momento storico è difficile pensare ad una riforma che ampli le garanzie democratiche. Il criminologo Adriano Morrone riprende i temi relativi al significato della pena. Ci ricorda che in questo momento è diffusa l’idea di pena come retribuzione, non tanto legata alla gravità del reato e quindi alla sua reale afflittività, quanto alla percezione dello stesso da parte di una società insicura e in crisi. Il legislatore non sta contrastando questa logica pericolosa, ma la sta accompagnando. Si susseguono, poi, i racconti di esperienze presenti sul territorio. Si ribadisce che le misure alternative non possono esistere senza il coraggio e la presenza del territorio. Il territorio in tutte le sue componenti deve essere attivo nella creazione di opportunità di inserimento e di inclusione. E questo soprattutto per contrastare la cosiddetta detenzione sociale, cioè la detenzione di chi fuori non trova opportunità di inclusione. Per loro, in gran parte immigrati e tossicodipendenti, il carcere diventa discarica, il luogo di nessuno in cui si rinchiude il fallimento dello stato sociale e di ogni politica preventiva. Bisogna agire, quindi, soprattutto all’esterno, senza però abbandonare le politiche carcerarie intese come politiche di riduzione del danno. In questo senso si muove il lavoro dell’altra grande fascia di esperienze che si stanno diffondendo sul territorio, quelle del difensore civico delle persone private della libertà personale. Esperienze che vedono protagonisti soprattutto gli enti locali. Al convegno era presente Franco Corleone, Garante nel comune di Firenze insieme all’assessore Marzia Monciatti, che ha voluto scommettere su questa nuova figura. Numerosi comuni e regioni stanno introducendo il Garante delle persone private della libertà. Ma perché il Garante possa espletare al meglio le sue funzioni anche a livello locale, sarebbe necessaria una legge nazionale che ne definisca i poteri. In questo momento, come sappiamo, giacciono in parlamento tre proposte di legge in materia. Dal convegno non nascono grandi proposte di cambiamento. Ma qui è il confronto che conta.
Abu Ghraib: le inferriate della democrazia, di Marco Incagnola
Il 27 aprile, quando la CBS ha trasmesso per la prima volta le sconvolgenti immagini delle mortificazioni fisiche e psichiche inferte dalle truppe anglo-americane ai prigionieri iracheni nel carcere di Abu Ghraib, il mondo prendeva definitivamente atto di una realtà tristemente nota. Il Comitato internazionale della Croce Rossa, in un rapporto di 25 indagini ispettive svolte in 14 centri di detenzione della coalizione, realizzato tra marzo e novembre 2003, metteva in luce una serie di maltrattamenti perpetrati allo scopo di “assicurarsi la cooperazione degli interrogati”; la redazione del documento, a conoscenza del capo dell’autorità provvisoria Paul Bremer e del comandante della coalizione Ricardo Sanchez, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni ufficiali dell’intelligence militare. Lo stesso rapporto mette in risalto un particolare inquietante: tantissimi reclusi (una percentuale che va dal 70 al 90%) sarebbero stati internati per errore; le violenze e le brutalità degli interrogatori sarebbero avvenute prima del trasferimento nei centri di prigionia gestiti dalla polizia militare, la cui correttezza è, secondo fonti ufficiali, garantita da rigorosi sistemi di controllo. Nonostante possano dirsi acclarate le responsabilità del Ministro della Difesa Rumsfeld che, secondo il Washington Post, approvò in prima persona la scelta di alcune metodologie 'persuasive', testualmente "non in linea con la dottrina statunitense standard" (metodi adottati a Guantanamo ed esportati dal generale Geoffrey Miller in Iraq), l’amministrazione Bush non ha fatto altro che ratificare la fiducia al capo del Pentagono e, dal punto di vista mediatico, diffondere presso alcune testate giornalistiche materiale relativo agli orrori delle torture commesse dal regime di Saddam Hussein, nel tentativo di mostrare all’opinione pubblica i progressi fatti in termini di civiltà! Il 19 maggio il processo-farsa del “fotografo” Jeremy Sivits ha voluto sollevare il governo americano da ogni responsabilità oggettiva, per liberarsi da quell’impasse diplomatico che, a detta di Rumsfeld, "sta facendo perdere molto tempo prezioso, distrae l’attenzione da quanto sta avvenendo in Afghanistan e in Iraq". E’ stata data poca risonanza alle dichiarazioni del generale dell’esercito americano Antonio Tubuga, che nella sua testimonianza/denuncia dichiarava che l’obiettivo di “estorcere” confessioni in funzione di una maggiore collaboratività della popolazione irachena era alla base della scelta del Pentagono di appaltare tale compito a due società private, la CACI e la TITAV. Se avesse senso introdurre dei distinguo nei reati contro l’umanità si potrebbe sostenere che ci si trova innanzi a un caso del tutto nuovo sia rispetto alle modalità in cui è avvenuto, che alla gestione della crisi da parte del governo americano. La tortura –come sostiene Françoise Sironi, psicoterapeuta delle vittime della violenza– ha lo scopo di far emergere i fantasmi più oscuri dell’esistenza e modifica brutalmente nelle vittime la rappresentazione mentale dell’ordine delle cose. In questo caso, però, pur volendo cercare un elemento di logica coerenza in una perversa prospettiva marziale, la violenza è stata finalizzata “all’umiliazione e alla spersonalizzazione del gruppo etnico ritenuto nemico”, in cui la specificità delle immagini gioca un ruolo altamente simbolico. La verità è che non si deve parlare neanche di “stato di eccezione”, ossia di sospensione dell’ordine giuridico come misura straordinaria, bensì di un tentativo di “ristrutturazione” del diritto internazionale. Gli Stati Uniti, d’altronde, sono tra i paesi che non hanno approvato né adottato il Protocollo ONU contro la tortura in virtù di una visione del diritto che introduce un inconciliabile iato tra sicurezza nazionale e difesa delle garanzie individuali. Inevitabilmente, quindi, la questione della tortura investe tutta la società civile in vista del superamento della logica delle singole responsabilità se è vero –come sostiene Amnesty International nel volume Non sopportiamo la tortura- che “impunità è quel meccanismo che tutela chi la ordina, chi la esegue e chi -in qualche modo- la facilita”!
Tutela dei figli di madri detenute straniere, di Laura Astarita
L’espulsione, a fine pena, delle detenute madri straniere, è stato il tema di un incontro-dibattito organizzato il 4 maggio scorso dall’associazione “A Roma insieme” e dalla Consulta cittadina permanente per i problemi penitenziari del Comune di Roma, della quale Antigone fa parte. In particolare, è stata presentata una proposta di modifica dell’attuale normativa che dispone l’espulsione, così da dare al giudice la possibilità di revocarla qualora si verifichino una serie di condizioni. Facciamo un passo indietro, anzi, restiamo al presente. Attualmente l’espulsione avviene: - una volta scontata la pena come misura di sicurezza, e in questo caso può essere revocata dal Magistrato di Sorveglianza, qualora non vi siano i presupposti per una pericolosità sociale; - come alternativa alla pena (residua e non superiore ai 2 anni) se comunque la persona fosse soggetta ad espulsione anche se libera; - a fine pena qualora un detenuto sia soggetto ad espulsione e tale misura non è ancora stata adottata, la stessa viene disposta immediatamente. Queste ultime due sono misure amministrative che vengono disposte automaticamente. Nessuna considerazione o spazio è concesso per i singoli percorsi di reinserimento per le donne per l’interesse superiore dei minori figli di queste persone. Minori che molto spesso sono perfettamente integrati nella società italiana, frequentano una scuola, parlano l’italiano dalla nascita, sono nati qui, e i cui genitori, dal canto loro, hanno fatto un percorso di reinserimento sociale che a volte li ha portati anche ad uscire da un contorto e tentacolare meccanismo di criminalità. Pensiamo alle donne rom costrette per regole sociali interne a rubare in giro, spesso con i propri figli con sé, che decidono, come è già successo, di lasciare il loro gruppo-famiglia di origine e di ricominciare una vita al di fuori di esso e delle sue regole. Inoltre bisogna sottolineare un perverso procedimento che si è instaurato, a causa del quale la persona straniera detenuta non può avere accesso alle misure alternative se non possiede permesso di soggiorno (sent. Sez. I Cassazione n. 30130 del 17/7/03), ma non possiede quasi mai tale permesso perché o entrata in carcere senza di esso o, comunque, una volta detenuta non può averne il rinnovo, in quanto ”autorizzata”/“costretta” a rimanere in Italia in forza del provvedimento dell’autorità giudiziaria (Circ. Min. Interno 2/12/00 e Messaggio Min. Interno alla Questura di Vercelli del 4 settembre 2001). In questo quadro normativo, bisogna dare centralità non solo al reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute, ma anche a quello delle madri per il superiore interesse dei minori che insieme ad esse verrebbero ad essere e sono nella pratica espulsi. Un primo appiglio lo offre l’art. 31 co. 3 del testo Unico; questo difatti prevede che il Tribunale dei Minori possa disporre che il minore per motivi di salute psico-fisica rimanga in Italia, e quindi che rimanga il genitore. È evidentemente debole come appiglio. La proposta presentata all’incontro viene descritta punto per punto da Sergio Briguglio, esperto di immigrazione della Fondazione Luigi di Liegro. Si tratterebbe di far passare 4 punti di sostanziale modifica della normativa attualmente in corso attraverso: - l’introduzione di una disposizione per la quale allo straniero sia rilasciato un permesso di soggiorno, in modo che non ricada sotto le disposizioni della sentenza della Cassazione sopra citata e che possa accedere alle misure alternative; - in riferimento all’espulsione come alternativa della pena, rendere questa misura facoltativa, su richiesta dello straniero; in questo caso, per esempio, uno straniero con dei figli potrebbe voler restare in carcere; - un rafforzamento dell’art. 31 co. 3 sopra citato, che preveda l’estensione di questa norma, che possa cioè essere adottata non solo dal Tribunale dei Minori, ma anche dal Ministero degli Interni, in particolare dal Prefetto. Si potrebbero inoltre introdurre dei criteri – come indicazione per le autorità che devono adottare questi provvedimenti – per esempio le condizioni di radicamento del minore in Italia, comparate a quelle nel paese dove andrebbe a stare; oppure l’essere, il suo soggiorno in Italia, non una scelta, ma un bisogno; - infine, l’espulsione come misura di sicurezza dovrebbe essere disposta, nel caso di presenza di figli, solo dal Tribunale dei Minori. Bisogna ricordare che l’anno scorso un importante emendamento passato alla Camera è stato bloccato dalla Lega al Senato con tutto l’art. 6 della legge sull’indultino. Tale emendamento prevedeva che l’espulsione delle straniere detenute madri potesse essere sospesa dal giudice nei seguenti casi: - quando esse avessero compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali competenti - quando i bambini risultassero inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale - quando le straniere in questione fossero provviste di un contratto di lavoro - quando esse avessero stabile domicilio, anche in case di accoglienza La proposta recentemente formulata sarà invece nelle prossime settimane presentata in Parlamento. All’incontro, infatti, dove erano rappresentate anche le istituzioni locali dagli assessori alle Politiche Sociali del Comune e della Provincia di Roma, rispettivamente Raffaella Milano e Claudio Cecchini, hanno partecipato e dichiarato la propria adesione all’iniziativa, le onorevoli Marcella Lucidi, Anna Finocchiaro, Maria Burani Procaccini (Presidente della Commissione bilaterale sull’Infanzia), Gabriella Pistone, Albertina Sogliani e la sen. Tana de Zulueta. Successivamente, hanno assicurato il loro appoggio Maura Cossutta, Giuliano Pisapia, Tiziana Valpiana e Rosy Bindi. Proprio questi parlamentari stanno attualmente discutendo e preparando le forme e i contenuti attraverso i quali provare a riportare all’attenzione una questione così delicata e così dimenticata come l’interesse del minore figlio di una detenuta straniera.
Le Iniziative di Antigone
Venerdì 18 giungo 2004 - A Perugia presso la Sala Partecipazione del Consiglio Regionale, sita in Piazza Italia 1, a partire dalle ore 9.30, Patrizio Gonnella interverrà in qualità di relatore al Seminario Europeo di studio e comparazione di casi italiani ed esteri del l’AUL, Agenzia Umbria Lavoro, ente strumentale della Regione Umbria, dal titolo: "Analisi dei fabbisogni formativi e definizione di modelli di intervento a favore della popolazione carceraria".
|